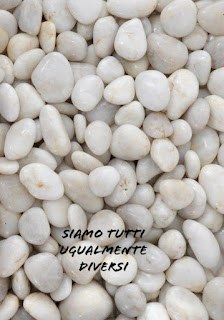Il tempo dell’attesa
Un
viaggio si intraprende con l’intenzione di raggiungere una meta. Ma i
protagonisti di un viaggio sono segnati dal percorso non dalla meta.
(‘Il
designer in azienda’, F. Bianco e L Rampini, FrancoAngeli ed., 2017)
Introduzione
Il
brutto dell’attesa è il non sapere quanto tempo potrà durare.
In
questo periodo di forzata ‘clausura’ (marzo 2020), in cui si è confinati in casa in attesa che
‘tutto passi’ e il corona virus si allontani, o si estingua per mancanza di
persone da infettare, può accadere di vivere il senso di impotenza come contrappunto al senso di onnipotenza coltivato e alimentato convenzionalmente.
Nella nostra società si è
sempre sollecitata la cura e l’espressione della forza e del coraggio nel
confronto con l’esistenza e, in linea con quest’indicazione, un messaggio
sociale chiaro e condiviso è stato quello di figurarsi di essere un combattente.
Questa prescrizione ha
portato con sé il rischio, per chi non ce la faceva, di sentirsi un debole o vigliacco.
Al contrario, l’idea
di soprassedere, di lasciar correre e di lasciar passare l’acqua ‘che
prima o poi porterà il cadavere del tuo nemico’, non è stata sempre accolta
con favore al punto d’essere considerata, a volte, come un pretesto per chi
aveva un comportamento pavido.
Quindi porsi in
attesa su un fiume ad osservare passare l’acqua, ha da sempre rappresentato ‘solo’
un messaggio filosofico che qualche (astrusa?) dottrina indica come strada da
intraprendere per una vita di saggezza. Magari la si è potuta immaginare praticabile negli
anni della vecchiaia, e quindi di là da venire, in quel periodo lontano dal momento attuale e dalla foga degli anni dell’arrivismo.
Quel che resta certo è che la
nostra società è una società consumistica dove ‘il tempo è danaro’ e l’attesa viene vista come incertezza,
titubanza, mancanza di idee chiare e confusione di obiettivi. E coloro
che indugiano generano impazienza e
rischiano di essere considerati indolenti e
pigri, se gli va bene, se no sono persone che andavano corretto fin da
piccoli e andavano educati a ‘… smetterla
di stare sempre con la testa tra le nuvole’, ma che tanto ormai sono destinati a non
saper cogliere il ‘principio di realtà’.
Il
minimo che possono comportare questi pre-giudizi sono i sensi di colpa che
alimentano costanti sentimenti di inadeguatezza in tante persone.
La forza dell’attesa
 Allora forse, questo periodo di forte limitazione del movimento, che l’intero paese sta vivendo, potrebbe servire a problematizzare il tema dell'attesa e si potrebbe indirizzare l’attenzione, non solo sul senso che il periodo dell’attesa
può avere per ognuno (giusto, sbagliato, noioso, insulso), ma anche sui modi che
ognuno ha di trascorrere questo ‘tempo passato in attesa’.
Allora forse, questo periodo di forte limitazione del movimento, che l’intero paese sta vivendo, potrebbe servire a problematizzare il tema dell'attesa e si potrebbe indirizzare l’attenzione, non solo sul senso che il periodo dell’attesa
può avere per ognuno (giusto, sbagliato, noioso, insulso), ma anche sui modi che
ognuno ha di trascorrere questo ‘tempo passato in attesa’.
Così forse sarebbe anche possibile che, sperimentando
ritmi e spazi diversi da quelli consueti, ci si potrebbe ravvedere e recuperare questa
grande dimensione che, costantemente denigrata, necessita di una legittima
riparazione.
L'aspettare
forzatamente (che il periodo di quarantena passi, che venga il nostro turno al
supermercato, che il raffreddore si attenui) che il tempo trascorri sta già
insegnando alcune pratiche cui non si era più abituati: per esempio che si può anche evitare di forzare le attività che richiedono due minuti
in uno e che il tempo non solo trascorre
ma, nel suo trascorrere, ha un suo reale valore.
Sta
insegnando che saper aspettare significa
essere in possesso di una capacità particolare e che chi indugia non è
necessariamente pavido o indeciso ma che, per certi versi, saper indugiare significa avere un un talento, un’attitudine positiva piuttosto che una debolezza.
Il
problema sta nel farlo con competenza così che possa rivelarsi un pregio che, allo stesso modo di una strategia di combattimento, possa essere utilizzato attivamente nell’at-tendere
verso lo scopo prefisso.
L’arte dell’attesa è
stata una strategia che l’uomo ha dovuto imparare a realizzare fin dai primordi
della sua esistenza mentre aspettava che l’animale uscisse dalla tana, che i
pesci entrassero nelle nasse, che il sole nascesse e i fiori sbocciassero, che gli
orti dessero i frutti e le api raccogliessero il nettare.
Ha dovuto sviluppare
quest’abilità per tutte le attività che, per essere apprese e poi svolte, richiedono
tempi e metodi e che, nella pazienza e nell'apparente tedio, alimentano la creatività. Così si è imparato ad aspettare il tempo necessario, dopo aver impastato
la farina e acceso un forno, che il pane cuocia e che i biscotti non
brucino. E si è anche imparato che, nelle battaglie e negli assedi di fortezze, città e
castelli, bisognava saper aspettare che l’aggredito soccombesse per il lungo logorio.
Così è l’Eroe a sapere e l’artigiano, l’uomo d’armi, a conoscere segreti che fanno presagire che quando l’attesa è faticosa non
dipende dal 'che cosa si sta aspettando' ma dal modo in cui l'attesa si realizza. Il contadino sa intuitivamente che l'attesa può logorare
tanto l’assediato quanto l’assediante e che risparmia solo colui che sa aspettare nel modo migliore.
In un contesto dove tutti aspettano qualcosa è risparmiato colui che sa
creare e trovare strategie alternative di ascolto e di osservazione degli
eventi, delle storie, e di ciò che sta accadendo così che la stessa attesa si rivela essere attività.
L’attesa
Un
modo per mettersi in attesa senza logorarsi è suggerito dalle tradizioni
sapienziali che insegnano il fatto che, per sostenere lunghi periodi di
immobilità fisica, è sufficiente prestare una costante attenzione alla consapevolezza del momento
presente o presenza mentale[i].
Interessante
è notare che, anche negli studi sull’intelligenza svolti dalla
ricerca neuropsicologica, la capacità attentiva si rivela come l’attitudine
maggiormente importante per l’intelligenza.
Particolarmente interessante sono
le ricerche sull’attenzione sostenuta[ii]
che, non potendo essere esercitata per lunghissimi periodi di tempo senza affaticamento,
va curata e protetta.
E' evidente che il pensiero costante
ad uno scopo recluta tutto l’organismo e lo pone in uno stato di tensione che lo
porta prima all’affaticamento e poi all’esaurimento, fisico e psichico. Tale
tensione solitamente non è avvertita perché subliminale ma genera comunque un
depauperamento energetico.
È per questo che nella vita normale, pur essendo
necessario conoscere lo scopo di ciò che si sta facendo, per evitare di esaurirsi
è necessario imparare strategie di recupero energetico. Una di queste è quella
di imparare a staccare il pensiero dall’obiettivo portando l’attenzione sulle stesse procedure adottate per
raggiungerlo.
Allo
stesso modo del perseguimento dell’obiettivo, anche questa strategia non va però realizzata
con accanimento ma rispettandone i tempi di ideazione, cosa si può fare, a sua volta, osservandone le
modalità, cioè il modo in cui si arriva a prestare attenzione al modo strategico ideato per realizzare lo scopo.
Ma
perché ci sia un rispetto adeguato dei tempi e ritmi, personalmente penso sia necessaria la presenza di un’altra variabile importante: la ‘spensieratezza’.
La spensieratezza non è necessariamente l’assenza di pensiero, o il volgersi del
pensiero ad aspetti ludici e superficiali distaccandosi dalla realtà (mind/wandering). La spensieratezza va recuperata alla capacità
di essere attenti e presenti senza obblighi né assilli e si lega alla fiducia perché solo quando si ha fiducia
si può essere rilassati pur lasciandosi avvolgere e coinvolgere dagli accadimenti.
Se per l’attuazione
di questi piani sono distanti e difficili gli insegnamenti sapienziali, allora si può fare riferimento a Winnicott
per avere un riferimento più occidentale e capire quanto il processo
dell’attenzione ‘non focalizzata’ appartiene naturalmente a tutti e ci guida
fin da piccoli[iii].
Proprio osservando i giochi dei bambini si potrebbe imparare, cercando di recuperarli, quei modi di partecipare alle azioni così coinvolgenti, come quando si immergono nell’esperienza fino a dimenticare di mangiare o di tornare a casa per andare in bagno.
In queste attività ludiche sono presenti dimensioni che crescendo si diluiscono e poi spariscono.
Per esempio la
passione e la capacità di esultare sono dimensioni psicologiche che smettono di
esistere con l’avanzare dell’età. Esse comprendono una partecipazione totale
dell’organismo che non si stancherebbe mai di essere presente e attento se solo
si riuscisse a non dimenticarle o a recuperarle.
Di fatto è nell’assorbimento con i loro giochi che i bambini imparano e i loro non sono solo voli fantastici. Sono anche viaggi in un vissuto
creato in quel momento, da ognuno di loro, con caratteristiche che
conferiscono a quel momento una unicità non replicabile.
È la creatività del
vissuto personale che si esprime incondizionatamente.
È quell’estro di
fantasia e giocosità che dona il senso del ‘piacere’ e che rende la vita
veramente degna di essere vissuta.
È quello che poi si
continua a cercare nel corso dell’intera esistenza e che rimane solo come
anelito nelle diverse attività adulte. È quella semplice capacità di gioire che
si disperde man mano che si cresce e si diventa consapevoli della propria
adultità.
 Da questo punto di
vista ‘saper attendere’ non è più solo aspettare
che il tempo passi ma rappresenta anche la capacità di cogliere le
occasioni di disimpegno per riprendere contatto con le proprie fantasie, con i
propri giochi pindarici, con le proprie gioie e piaceri che si è sacrificati al dio del
rendimento e della prestazione.
Da questo punto di
vista ‘saper attendere’ non è più solo aspettare
che il tempo passi ma rappresenta anche la capacità di cogliere le
occasioni di disimpegno per riprendere contatto con le proprie fantasie, con i
propri giochi pindarici, con le proprie gioie e piaceri che si è sacrificati al dio del
rendimento e della prestazione.
Rappresenta
l’occasione per meglio osservarsi, per guardarsi dentro e da fuori scoprire che
si è soli o insieme, e che si è rimasti coinvolti, anche da grandi e pur senza
desiderarlo, in giochi individuali, di coppia o di gruppo che ci possono stare
stretti o larghi. Che questi momenti e
spazi si sanno e si possono comunque vivere oppure, al contrario, che fanno paura e non si è capaci
di viverli perché, quando ci si accorge di essere soli, si può scoprire di non saper più
vivere da soli e ci si può svuotare d’aria fino a sentirsi persi nella propria
individualità.
Ci
si può scoprire soli e aver paura anche di stare da soli.
Il
rispetto dell’attesa
Quella
di saper aspettare è una dimensione importante in ogni attività ma nell’attività
psicoterapeutica lo è in maniera particolare.
Nello
spazio analitico l’attesa, e il saper attendere, acquistano un valore che
semplifica e delucida il senso del rispetto laddove il senso di ogni
psicoterapia è dato dalla capacità di tradurre il tempo dell’attesa, del saper
aspettare appunto, nella comprensione dell’individuo.
Sin dal concepimento
l’organismo umano si realizza eseguendo ritmi che soddisfano bisogni intrinseci
dell’individuo e di cui la persona non è consapevole.
Nel corso
dell’evoluzione questi bisogni si modificano incorporando messaggi ed esigenze
ambientali che trasformano l’individuo in una persona con un suo carattere, una
sua forma (fisica e mentale) un suo ritmo (di apprendimento, nutritivo,
respiratorio ecc.) ed una sua modalità di relazionarsi.
Quest’ultima modalità
sarà quella che, cristallizzandosi, impedisce alla persona di continuare
ad imparare ad imparare (questa
ripetizione non è un refuso. Nota dell’autore) nel corso dell’intera
esistenza. Ciò accade perché il modo in cui si apprende ad interagire nelle
prime esperienze neonatali sarà quello che più facilmente, e
consuetudinariamente, verrà utilizzato nelle relazioni.
L’abitudine e la
consuetudine, come tutte le routine, saranno una garanzia ma anche un limite
perché, pur soddisfacendo una economia generale (così facendo l’organismo si
adatta ad una sopravvivenza fatta del minimo
impegno e massimo rendimento) in realtà tale garanzia si concretizza solo
capitalizzandosi in una economia prestazionale che l'organismo, così facendo, sostiene.
Di contro ciò
comporta un irrigidimento delle modalità di apprendimento e delle modalità di
relazione che, configurandosi come espressioni caratteriali, modificano anche
l’attitudine di imparare ad imparare.
Ma fortunatamente, caratteriale non
vuol dire immodificabile e lo sanno gli operatori della
salute mentale che sono coloro che, presto o tardi, imparano a fare del saper aspettare e dell’imparare ad imparare gli strumenti principe dell’aiuto
psicologico.
Capita spesso di rivolgersi alla psicoterapia per diversi motivi che, in qualche modo, possono essere ricondotti soprattutto al
bisogno di allentare le maglie della capacità di apprendimento che, nel corso
del tempo tendono un po’ ad irrigidirsi. Per esempio, quando ci si
rende conto di non riuscire a venir fuori da pensieri assillanti, da modalità
di relazione ridondanti, da schemi mentali fissi che danno sempre gli stessi
risultati e ci si rende conto di aver dimenticato
come si impara (ad aprire una nuova finestra nella mente e qual è il
profumo dell’aria pulita e il gusto della vicinanza amicale o intima, d’amicizia
o d’amore), allora si avverte, e a volte anche si coglie, il bisogno di dover
imparare a guardare la realtà in modi diversi da quelli abituali e di dover
anche re/imparare modi nuovi per imparare.
Da
queste esperienze sorge una domanda complessa che, appartenendo all'organismo nel suo complesso, si rivela sovradeterminata
rispetto a tutti gli indirizzi di psicoterapia cui spetta il compito della risposta.
Ma in realtà per rispondere
a questa domanda non esistono strumenti codificati e anche gli psicoterapeuti, il
più delle volte, si devono adoperare da soli ed imparare di propria iniziativa a
sviluppare una nuova capacità d’osservazione che, come per i bambini, sia
correlata e non distinta dall’assorbimento esperienziale gaudioso.
Negli anni dei giochi
di formazione professionale gli psicoterapeuti imparano da soli ad aspettare e, mentre aspettano, ad essere orecchie ed
occhi. Imparano a ri/diventare curiosi del modo
in cui le persone si relazionano, di come si raccontano, di come respirano mentre
fanno le cose che fanno e come, così facendo, osservano, ascoltano e annusano il
tempo che passa. Re/imparano ad at/tendere che le persone trovino la fiducia
nello spazio analitico, che vi si adattino a proprio modo dispiegando il loro modo di sognare la vita e costruire l’esistenza che è soggettivo, individuale e personale.
Quando anche per gli psicoterapeuti arriva il momento dell’attesa, accade un pò come per tutti ai tempi del COVID
19. Ci si accorge drammaticamente dell’improvvisa sparizione dei rituali catartici, svuotati e poi dissoltisi nel tempo delle tecnologie avanzate. Si scopre la frequente inconsapevolezza della sofferenza come dell’amore e nella vita, come in terapia, si scopre la necessità di un cambio di registro e che è necessario smetterla di affannarsi nella corsa e che è necessario fermarsi.
Rallentare, indugiare, fermarsi e respirare.
Paradossalmente
è solo nei momenti di vuoto che si impara la pienezza dell'attesa e a fornire alle proprie
attitudini la perspicacia dell’indugio, dimensione in cui è possibile cogliere il rispetto
del ritmo e del tempo delle modalità di passaggio. Di quei momenti
soggettivamente unici di transito, da cui è puntellata la nostra crescita, e
che da un momento all’altro, da una sponda all’altra e da una separazione a un
approdo, danno conto di una soggettività che, avendo perso il salvagente dei
riti, cerca in una relazione la riparazione per riprendere a imparare e per continuare ad essere.
Giuseppe Ciardiello
[i]
Questa strategia, a volte chiamata della ‘nuda’ o ‘pura’ attenzione, consiste
in una “chiara e sicura consapevolezza di ciò che realmente avviene a noi e in noi, nei successivi momenti di percezione ”. Differisce dalla
nostra ordinaria modalità percettiva in quanto è distaccata e ricettiva, e
permette di registrare accuratamente qualunque cosa accada nella mente e nel
corpo, distinguendo attentamente le reazioni mentali ed emotive degli eventi in
sé e per sé. (M.
Epstein, ‘Psicoterapia senza l’Io’, Astrolabio, 2008, p. 141)
[ii] la
capacità di sostenere la prontezza di risposta agli stimoli per il tempo
richiesto da un compito
[iii]
(Winnicott) prendendo le mosse dall’esperienza infantile, il suo discorso
riesce a spiegare qualcosa che anche il buddhismo, a modo suo, sottolinea: lo
stato della nuda attenzione ci è connaturato. (M. Epstein, 2008, p. 145)